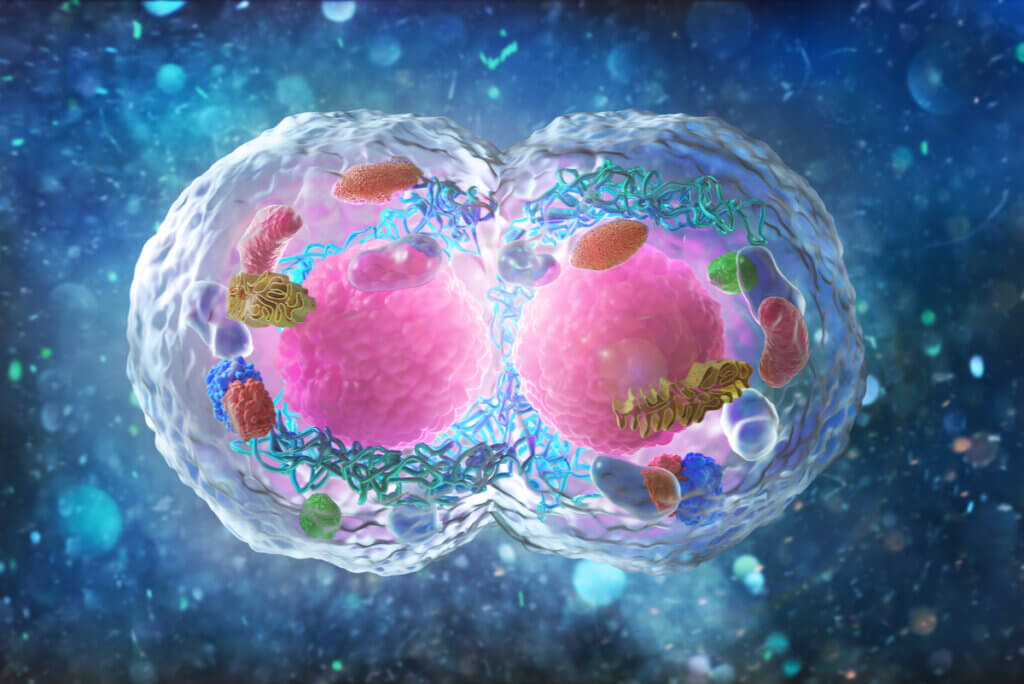Disturbi dell'attenzione e processi attentivi

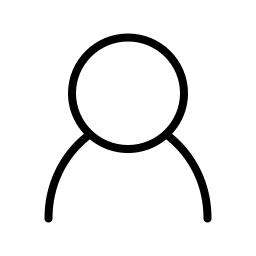
Escrito y verificado por el psicólogo Bernardo Peña
I disturbi dell’attenzione sono comuni in molte psicopatologie. Che siano primari o sussidiari, comportano una notevole riduzione della capacità di azione e di coordinamento dei restanti processi cognitivi. In questo articolo esamineremo cos’è l’attenzione, nonché le sue principali alterazioni o disturbi.
Attenzione
L’attenzione è un processo psicologico di base che guida e coordina l’attività dei nostri sensi e pensieri e permette quindi la selezione, la distribuzione e il mantenimento di tutta l’attività cognitiva.
Pertanto, come processo, consente di filtrare il flusso di informazioni ricevute dall’organismo e focalizzare l’attività psichica su uno stimolo o area specifica del campo di coscienza. Quest’ultima è la capacità di comunicare tra l’ambiente interno ed esterno.
L’attenzione è necessaria ad altri processi più complessi, come l’apprendimento o la memoria; si può stabilire così un ordine gerarchico, dove il suo funzionamento condiziona gli altri. Affinché l’attenzione esista, è essenziale che vi sia un certo grado di coscienza così come l’alterazione di questa influisce sull’efficienza dell’attenzione e, quindi, degli altri processi psicologici.
La funzione attentiva
Come accennato, l’attenzione indirizza le nostre risorse mentali verso stimoli specifici. Questo processo può essere suddiviso in tre fasi:
- Iniziazione attenzionale: consiste nella cattura dell’attenzione in modo passivo o attivo. Il processo passivo è involontario: l’attenzione viene catturata dai vari cambiamenti che si verificano nell’ambiente esterno e interno. Nel processo attivo distinguiamo gli stimoli a seconda delle esigenze dell’organismo.
- Mantenimento dell’attenzione o focus sull’oggetto per l’elaborazione delle informazioni.
- Cessazione del processo attenzionale: slittamento dell’attenzione verso un altro stimolo rilevante per l’organismo. Ciò può essere dovuto a meccanismi di assuefazione e affaticamento sensoriale, dalla volontà del soggetto, o anche dall’irruzione di uno stimolo nuovo e moderatamente saliente.

Potrebbe interessarvi anche: Disturbo post-traumatico da stress: sintomi e caratteristiche
Attenzione: processi automatici o controllati
All’interno dei processi cognitivi, si possono distinguere quelli in cui è necessario il controllo attivo e quelli in cui non lo è:
- I processi automatici non comportano un livello significativo di controllo cosciente. Si possono verificare contemporaneamente più processi automatici.
- I processi controllati richiedono invece un certo livello di attenzione e consapevolezza. Questi processi avvengono in sequenza e la loro durata può essere maggiore di quelli automatici.
I processi automatici mancano di controllo volontario. Ciò può essere evidenziato nell’apprendimento non associativo, come l’assuefazione (risposta ridotta derivante dall’esposizione ripetuta a uno stimolo) o la sensibilizzazione (risposta aumentata derivante dall’esposizione ripetuta a uno stimolo). Esistono anche altri comportamenti che si automatizzano nel tempo.
Quando si impara a guidare, ad esempio, inizialmente è necessario un controllo cosciente e un’attenzione focalizzata su ogni azione eseguita. Successivamente, man mano che queste azioni migliorano e aumenta l’efficienza, il controllo cosciente non è più richiesto, essendoci un numero maggiore di risorse cognitive per altre azioni concomitanti.
Azioni automatizzate
Le azioni possono diventare relativamente automatiche, ma se necessario sarà possibile rivolgere l’attenzione su di esse. Questo può essere osservato in qualsiasi comportamento o movimento intenzionale, in cui la procedura è così interiorizzata da essere stereotipata. Il controllo volontario ricade sull’inizio e sul completamento dell’azione, come masticare una gomma o andare in bicicletta.
Grazie a questo fenomeno, si possono realizzare azioni più complesse, in cui i processi che non richiedono attenzione focalizzata passano in secondo piano, consentendo al corpo di mantenere l’attenzione su altre azioni che la richiedono.
In caso contrario sarebbe praticamente impossibile fondere movimenti grossolani e sottili come nella scrittura o nella pittura. Ovvero non si potrebbe controllare in modo consapevole i movimenti delle dita su una matita e, allo stesso tempo, il movimento del braccio.
Funzioni dell’attenzione
Le funzioni dell’attenzione sono precisamente quelle coinvolte quando si verificano alterazioni o disturbi o dell’attenzione. Le principali funzioni sono:
- Valutazione: è la capacità di ricercare e localizzare nel campo percettivo; permette di riconoscere schemi e significati.
- Focalizzazione: discriminazione nel campo percettivo che consente di selezionare uno stimolo ed eliminare gli altri.
- Filtro: classificazione degli stimoli come rilevanti o irrilevanti. Questa capacità viene alterata nei disturbi da deficit di attenzione.
- Capacità attentiva: si riferisce alla quantità di elementi a cui il soggetto può prestare attenzione allo stesso tempo all’interno di una determinata attività.
- Attenzione simultanea: capacità di prestare attenzione allo stesso tempo a diversi elementi di diverso contenuto.

Elementi dell’attenzione
L’attenzione può essere:
- Involontaria: è caratterizzata da uno stato di vigilanza e eccitazione. Il soggetto non è orientato ad uno stimolo specifico nell’ambiente, non ha un particolare interesse. È una specie di attenzione “di routine”.
- Spontanea: la comparsa improvvisa o inaspettata di stimoli attira l’attenzione, che si focalizza su di essi.
- Volontaria: è presente la ricerca intenzionale e il monitoraggio di uno stimolo specifico.
- Sostenuta: detta anche concentrazione, si riferisce al mantenimento costante dell’attenzione basata su un’analisi prolungata nel tempo, in cui possono essere coinvolti più sensi.
- Selettiva: gli stimoli vengono filtrati e focalizzati sullo stimolo ritenuto rilevante, eliminandone altri, considerati distrattori.
- Alternanza: detta anche flessibilità cognitiva, si riferisce al cambiamento focale tra stimoli diversi.
- Divisa: attenzione simultanea di più di uno stimolo; le informazioni che provengono dagli stimoli sono elaborati contemporaneamente.
Disturbi dell’attenzione
Alterazioni quantitative dovute a una maggiore attenzione:
- Iperprosessia: esacerbazione dell’attenzione volontaria; il soggetto si concentra su qualcosa in modo ossessivo e il resto degli stimoli non sono in grado di suscitare la sua attenzione.
- Depolarizzazione dell’attenzione: l’attenzione si polarizza verso stimoli provenienti dall’interno del soggetto, isolandosi dagli stimoli esterni.
Alterazioni quantitative dovute alla diminuzione dell’attenzione:
- Ipoprosessia: marcata diminuzione della capacità attentiva.
- Aprosessia: incapacità completa di prestare attenzione.
- Pseudo-aprosessia: è presente aprosessia, ma l’attenzione è focalizzata sull’ambiente esterno dell’individuo.
- Para-prosessia: si verificano deviazioni involontarie dell’attenzione. A causa del danno dell’attenzione volontaria, viene amplificata l’attenzione spontanea. Inoltre, si osserva un aumento psicomotorio.
Leggete anche: Disturbi di personalità
Conclusioni sui processi attentivi e loro alterazioni
L’attenzione è essenziale per coordinare e dirigere il resto dei processi cognitivi; anche per compiere specifici atti volontari. I disturbi dell’attenzione suppongono una parziale mancanza di coordinazione o simili del nostro sistema mentale. In questi casi è conveniente distinguere tra alterazioni lievi o patologiche, temporanee o permanenti, ed eventualmente sarà necessario un trattamento neuropsichiatrico.
I disturbi dell’attenzione sono comuni in molte psicopatologie. Che siano primari o sussidiari, comportano una notevole riduzione della capacità di azione e di coordinamento dei restanti processi cognitivi. In questo articolo esamineremo cos’è l’attenzione, nonché le sue principali alterazioni o disturbi.
Attenzione
L’attenzione è un processo psicologico di base che guida e coordina l’attività dei nostri sensi e pensieri e permette quindi la selezione, la distribuzione e il mantenimento di tutta l’attività cognitiva.
Pertanto, come processo, consente di filtrare il flusso di informazioni ricevute dall’organismo e focalizzare l’attività psichica su uno stimolo o area specifica del campo di coscienza. Quest’ultima è la capacità di comunicare tra l’ambiente interno ed esterno.
L’attenzione è necessaria ad altri processi più complessi, come l’apprendimento o la memoria; si può stabilire così un ordine gerarchico, dove il suo funzionamento condiziona gli altri. Affinché l’attenzione esista, è essenziale che vi sia un certo grado di coscienza così come l’alterazione di questa influisce sull’efficienza dell’attenzione e, quindi, degli altri processi psicologici.
La funzione attentiva
Come accennato, l’attenzione indirizza le nostre risorse mentali verso stimoli specifici. Questo processo può essere suddiviso in tre fasi:
- Iniziazione attenzionale: consiste nella cattura dell’attenzione in modo passivo o attivo. Il processo passivo è involontario: l’attenzione viene catturata dai vari cambiamenti che si verificano nell’ambiente esterno e interno. Nel processo attivo distinguiamo gli stimoli a seconda delle esigenze dell’organismo.
- Mantenimento dell’attenzione o focus sull’oggetto per l’elaborazione delle informazioni.
- Cessazione del processo attenzionale: slittamento dell’attenzione verso un altro stimolo rilevante per l’organismo. Ciò può essere dovuto a meccanismi di assuefazione e affaticamento sensoriale, dalla volontà del soggetto, o anche dall’irruzione di uno stimolo nuovo e moderatamente saliente.

Potrebbe interessarvi anche: Disturbo post-traumatico da stress: sintomi e caratteristiche
Attenzione: processi automatici o controllati
All’interno dei processi cognitivi, si possono distinguere quelli in cui è necessario il controllo attivo e quelli in cui non lo è:
- I processi automatici non comportano un livello significativo di controllo cosciente. Si possono verificare contemporaneamente più processi automatici.
- I processi controllati richiedono invece un certo livello di attenzione e consapevolezza. Questi processi avvengono in sequenza e la loro durata può essere maggiore di quelli automatici.
I processi automatici mancano di controllo volontario. Ciò può essere evidenziato nell’apprendimento non associativo, come l’assuefazione (risposta ridotta derivante dall’esposizione ripetuta a uno stimolo) o la sensibilizzazione (risposta aumentata derivante dall’esposizione ripetuta a uno stimolo). Esistono anche altri comportamenti che si automatizzano nel tempo.
Quando si impara a guidare, ad esempio, inizialmente è necessario un controllo cosciente e un’attenzione focalizzata su ogni azione eseguita. Successivamente, man mano che queste azioni migliorano e aumenta l’efficienza, il controllo cosciente non è più richiesto, essendoci un numero maggiore di risorse cognitive per altre azioni concomitanti.
Azioni automatizzate
Le azioni possono diventare relativamente automatiche, ma se necessario sarà possibile rivolgere l’attenzione su di esse. Questo può essere osservato in qualsiasi comportamento o movimento intenzionale, in cui la procedura è così interiorizzata da essere stereotipata. Il controllo volontario ricade sull’inizio e sul completamento dell’azione, come masticare una gomma o andare in bicicletta.
Grazie a questo fenomeno, si possono realizzare azioni più complesse, in cui i processi che non richiedono attenzione focalizzata passano in secondo piano, consentendo al corpo di mantenere l’attenzione su altre azioni che la richiedono.
In caso contrario sarebbe praticamente impossibile fondere movimenti grossolani e sottili come nella scrittura o nella pittura. Ovvero non si potrebbe controllare in modo consapevole i movimenti delle dita su una matita e, allo stesso tempo, il movimento del braccio.
Funzioni dell’attenzione
Le funzioni dell’attenzione sono precisamente quelle coinvolte quando si verificano alterazioni o disturbi o dell’attenzione. Le principali funzioni sono:
- Valutazione: è la capacità di ricercare e localizzare nel campo percettivo; permette di riconoscere schemi e significati.
- Focalizzazione: discriminazione nel campo percettivo che consente di selezionare uno stimolo ed eliminare gli altri.
- Filtro: classificazione degli stimoli come rilevanti o irrilevanti. Questa capacità viene alterata nei disturbi da deficit di attenzione.
- Capacità attentiva: si riferisce alla quantità di elementi a cui il soggetto può prestare attenzione allo stesso tempo all’interno di una determinata attività.
- Attenzione simultanea: capacità di prestare attenzione allo stesso tempo a diversi elementi di diverso contenuto.

Elementi dell’attenzione
L’attenzione può essere:
- Involontaria: è caratterizzata da uno stato di vigilanza e eccitazione. Il soggetto non è orientato ad uno stimolo specifico nell’ambiente, non ha un particolare interesse. È una specie di attenzione “di routine”.
- Spontanea: la comparsa improvvisa o inaspettata di stimoli attira l’attenzione, che si focalizza su di essi.
- Volontaria: è presente la ricerca intenzionale e il monitoraggio di uno stimolo specifico.
- Sostenuta: detta anche concentrazione, si riferisce al mantenimento costante dell’attenzione basata su un’analisi prolungata nel tempo, in cui possono essere coinvolti più sensi.
- Selettiva: gli stimoli vengono filtrati e focalizzati sullo stimolo ritenuto rilevante, eliminandone altri, considerati distrattori.
- Alternanza: detta anche flessibilità cognitiva, si riferisce al cambiamento focale tra stimoli diversi.
- Divisa: attenzione simultanea di più di uno stimolo; le informazioni che provengono dagli stimoli sono elaborati contemporaneamente.
Disturbi dell’attenzione
Alterazioni quantitative dovute a una maggiore attenzione:
- Iperprosessia: esacerbazione dell’attenzione volontaria; il soggetto si concentra su qualcosa in modo ossessivo e il resto degli stimoli non sono in grado di suscitare la sua attenzione.
- Depolarizzazione dell’attenzione: l’attenzione si polarizza verso stimoli provenienti dall’interno del soggetto, isolandosi dagli stimoli esterni.
Alterazioni quantitative dovute alla diminuzione dell’attenzione:
- Ipoprosessia: marcata diminuzione della capacità attentiva.
- Aprosessia: incapacità completa di prestare attenzione.
- Pseudo-aprosessia: è presente aprosessia, ma l’attenzione è focalizzata sull’ambiente esterno dell’individuo.
- Para-prosessia: si verificano deviazioni involontarie dell’attenzione. A causa del danno dell’attenzione volontaria, viene amplificata l’attenzione spontanea. Inoltre, si osserva un aumento psicomotorio.
Leggete anche: Disturbi di personalità
Conclusioni sui processi attentivi e loro alterazioni
L’attenzione è essenziale per coordinare e dirigere il resto dei processi cognitivi; anche per compiere specifici atti volontari. I disturbi dell’attenzione suppongono una parziale mancanza di coordinazione o simili del nostro sistema mentale. In questi casi è conveniente distinguere tra alterazioni lievi o patologiche, temporanee o permanenti, ed eventualmente sarà necessario un trattamento neuropsichiatrico.
- Beltrán, J. (1996). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis.
- Blázquez-Alisente, J. L., Paúl-Lapedriza, N., & Muñoz-Céspedes, J. M. (2004). Atención y funcionamiento ejecutivo en la rehabilitación neuropsicológica de los procesos visuoespaciales. Rev Neurol, 38(5), 487-495.
- Caballo, V. E., Salazar, I. C., & Carrobles, J. A. I. (2014). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Pirámide.
- Peña-Herrera, B. (2018) Psicopatología General. Samborondón: Universidad Espíritu Santo – Ecuador
Este texto se ofrece únicamente con propósitos informativos y no reemplaza la consulta con un profesional. Ante dudas, consulta a tu especialista.